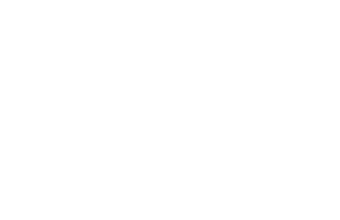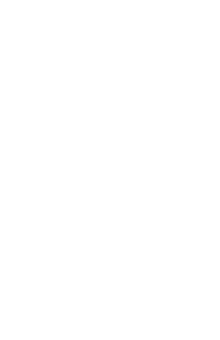Mario Jacchia
Avvocato, uno dei fondatori del Partito d’Azione, faceva parte del Comitato di Liberazione Nazionale bolognese, comandante delle formazioni militari dell’Emilia Nord, fu arrestato a Parma durante una riunione mentre favoriva la fuga dei suoi compagni. Torturato e ucciso ricevette la Medaglia d’oro alla memoria.
Alle ore 15 circa, transitava da Piazza Garibaldi l’alta figura di Mario Jacchia, dignitoso, impassibile, circondato dalla sbirraglia fascista. Un tedesco che incontrò il gruppo fa l’atto di colpire il prigioniero col calcio del fucile. Jacchia non si scompone, continua il suo cammino a testa alta, sicuro di rappresentare l’Italia del nuovo risorgimento, un combattente per la democrazia”.
Questa è la storia di Mario Jacchia, ufficiale degli Alpini nella Grande Guerra, vittima delle leggi antiebraiche, tra i fondatori del Partito D’Azione. Durante la Resistenza, è stato comandante militare di tutte le formazioni della Zona Nord dell’Emilia. Catturato a Parma, durante una riunione, mentre incitava i compagni a fuggire, imprigionato e torturato, il suo corpo non è stato mai ritrovato. È medaglia d’oro alla memoria.
Figlio dell’avvocato Eugenio e di Elisabetta Carpi, Mario Jacchia, nasce a Bologna il 2 gennaio del 1896. Il padre, massimo esponente della massoneria bolognese, era riparato nel capoluogo emiliano in seguito all’espulsione da Trieste, da parte dal governo austriaco, per la sua attività irredentista, in concomitanza con l’arresto di Guglielmo Oberdan con cui aveva cospirato in favore dell’Italia.
Mario, ancora liceale, è promotore e protagonista di organizzazioni patriottiche. Convinto interventista, lascia l’università e partecipa, da volontario fra gli alpini, alla Grande guerra, ottenendo il grado di ufficiale e importanti decorazioni al valore. Dopo la smobilitazione, riprende gli studi in giurisprudenza. Attratto inizialmente dal fascismo, se ne allontana in seguito alla bastonatura subita il 28 giugno 1924 dal fratello Luigi che militava in campo antifascista, forse in seguito all’esaltazione che colse i fascisti per l’assassinio del deputato socialista Giacomo Matteotti avvenuto il 10 giugno precedente. In disprezzo al vecchio avvocato Eugenio Jacchia, i fascisti lasciarono davanti al suo studio, in via d’Azeglio 58, una bara riempita con cimeli e simboli della massoneria. Il 3 gennaio del 1925, lo studio di avvocato dei Jacchia viene devastato dai fascisti. Giunto sul posto mentre mobili e pratiche sono divorate dal fuoco, Mario Jacchia spara contro gli assalitori.
“Per il delitto Matteotti, Mario si dimise dal partito fascista ed una squadraccia andò a bruciargli lo studio: era notte e lui tornava a casa con la moglie. Nascose la moglie dietro le colonne di un portico, affrontò i teppisti comandati da Bonaccorsi con due rivoltelle: fu picchiato a sangue ma riuscì a mettere in fuga i violenti e a spegnere l’incendio appiccato”. Al Commissario di polizia che lo invitava ad andarsene disse: “Mi lasci fare, sono un decorato di 4 medaglie e non ho paura”.
Dopo questo episodio, Jacchia passa decisamente all’antifascismo. Il 18 luglio 1936 scoppia la guerra civile spagnola che vede fronteggiarsi la Repubblica del Fronte Popolare delle sinistre e le forze di destra del generale Francisco Franco. Da una e dall’altra parte arrivano rinforzi internazionali: a sostegno di Franco, Mussolini manda un contingente di 50.000 uomini del regio esercito, Hitler invia una squadriglia dei suoi nuovi aerei che voleva testare; dall’altra parte, contingenti internazionali di volontari antifascisti a sostegno della Repubblica accorrono in Spagna. Tra loro c’è anche il cugino di Mario, Piero Jacchia; inizialmente, anch’egli fervente fascista, poi volontario antifascista aggregatosi al Battaglione Garibaldi e ucciso da un proiettile in piena fronte il 28 gennaio 1937.
Così Giancarlo Sacerdoti, amico di famiglia, ricorda un episodio svoltosi in un pomeriggio a casa Jacchia a Bologna, che frequentava assiduamente assieme ai genitori.
“…Il discorso cadde su Piero Jacchia il cugino di Mario, comunista, che era andato a combattere la sua guerra in Spagna ed era morto colà lasciando come unico ricordo un libriccino di poesie e qualche scritto”. “Povero Piero andare a morire lontano dalla patria, dai parenti, dagli amici! Commentava mio padre”. “Caro Titì, (così confidenzialmente Mario chiamava papà fin da quando si conoscevano da ragazzi) morire per la propria idea è un privilegio che gli Dei concedono a pochi. Piero è stato fortunato!” rispose Jacchia. “L’immagine di quel forte amico mi parve grandissima in quella penombra e la frase non fu “retorica”. Gli Dei avrebbero concesso a Mario lo stesso privilegio. Mi ricordai di un poema sugli ebrei marrani bruciati vivi nel 1500 ad Ancona per non aver accettato di abiurare la propria fede e tra questi veniva ricordato il “grande e forte Jacchia”. Mi ricordai, nel buio, di quelle storie di antichi eroi”.
Intanto, a Bologna, Mario Jacchia, per le sue idee ormai apertamente antifasciste affronta una serie di traversie burocratiche e di persecuzioni amministrative.
All’inizio del 1943 aderisce al Partito d’Azione. È amico e compagno di Massenzio Masia, capo spirituale di quel Partito in Emilia, ed è anche amico e compagno dell’altro militante antifascista bolognese di famiglia ebraica, Mario Finzi.
L’8 settembre è a Roma dove, a Porta San Paolo, partecipa agli scontri con l’esercito tedesco che avanzava sulla città. Rientrato a Bologna, è il primo rappresentante del Partito d’Azione all’interno del Comitato di Liberazione Nazionale-CLN bolognese. Ai primi del 1944 lascia questo incarico politico per assumerne altri di carattere militare. Con il nome di battaglia “Rossini”, gli affidano il comando militare di tutte le forze partigiane del nord Emilia. Nel luglio del 1944 prende il comando della delegazione di Parma con giurisdizione sulle province di Reggio Emilia, Piacenza, Parma, Modena, divenendo l’instancabile animatore del movimento. Si prodiga con tutte le sue energie per organizzare e potenziare le formazioni che ben presto si accrescono fino a diventare decine di brigate partigiane.
Il 3 agosto 1944 si trova a Parma in via Parmigianino, nella sede del comando, insieme con altri tre partigiani. Alle 14,30 la casa viene circondata dalle brigate nere per ordine del federale Romualdi. Messi in allarme, i 4 fuggono attraverso i tetti, ma Mario, ricordando che nella stanza erano rimaste carte importanti, ritorna indietro per distruggerle. Mentre è intento a bruciare i documenti, la polizia irrompe nell’appartamento e lo arresta.
Consegnato all’autorità tedesca di Parma, è rinchiuso in un edificio di fronte alle carceri di Petitò, dove il giorno dopo viene imprigionato anche il dirigente comunista Giorgio Amendola che fa parte del comando militare generale delle Brigate Garibaldi. E che non è, per fortuna, riconosciuto come tale.
Ecco che cosa scrive Amendola a proposito di quegli stessi giorni dei primi di agosto del 1944:
“…ad un certo punto Suardi [Emilio detto Rino] arrivò tutto trafelato e impolverato. Si era salvato per un pelo dall’arresto: la casa del comando dove abitava Jacchia era stata circondata e le SS erano salite per procedere all’arresto. Allarmati in tempo, erano fuggiti da una finestra che dava sui tetti. Ma all’ultimo momento, Jacchia era tornato indietro per tentare di portare in salvo delle carte. “Vai avanti aveva detto”. Ma non era più tornato. Rino era passato sul tetto di un’altra casa poi si era lasciato scivolare lungo un tubo e si era dato alla fuga nel dedalo delle stradine. Sicuro di non essere seguito era giunto finalmente alla casa di Giacchetti. L’arresto di Jacchia era un colpo duro. Per circondare la casa le SS dovevano essere ben informate. Che cosa avrebbero trovato nelle carte lasciate nell’abitazione? Era necessario prendere delle misure di sicurezza…”
L’indomani, Amendola aveva fissato un appuntamento alle otto a Porta S. Lazzaro con Cesare Campioli e, racconta nel suo libro “Lettere a Milano”:
“…ad un certo punto, mentre camminavo tutto tranquillo lungo il viale della Circonvallazione, vidi Campioli venire avanti con la bicicletta, Giacchetti con le mani alzate e dietro a loro due SS con i mitra imbracciati ed una macchina tedesca con altra gente a bordo. Fu per me una doccia fredda. Non potevo svoltare perché, in quel punto del viale, non c’erano traverse vicine, non potevo fare dietro-front senza attirare l’attenzione dei tedeschi. Dovevo sforzarmi di continuare ad avanzare tranquillo…” “…vidi arrivare , a passo di corsa, i due SS. Mi afferrarono e mi spinsero verso l’automobile, dove fui cacciato con la valigia. Inutili le mie proteste indignate. Ci portarono davanti al Petitò, in un palazzo dove aveva sede il comando delle SS e della polizia tedesca…” “…Non fummo perquisiti… Mi chiesero le generalità… Poi fui spinto in uno scantinato e messo in una cantina dove c’era una branda…” “…cominciò l’attesa, lunga, pesante, tormentata dalla rabbia di essermi fatto prendere come un imbecille… La sera l’attesa divenne più drammatica… Poi vidi trascinare giù per le scale una persona che si reggeva a stento in piedi, la camicia macchiata di sangue un occhio pesto e la faccia tumefatta. Dall’aspetto riconobbi l’avvocato Jacchia, il Rossini contro il quale avevo così animosamente e polemicamente scritto nella lettera precedente. Adesso stavamo assieme in mano al nemico e l’unità politica acquistava un nuovo significato per le nostre persone, diventava solidarietà umana.”
“… Qualche ora più tardi nel corso della notte fui chiamato e portato al piano superiore per essere a mia volta interrogato. C’era un ufficiale tedesco che parlava un ottimo italiano. Mi chiese se ero l’avvocato Re, un avvocato romano, e se avevo avuto, alle otto di mattina del giorno ormai trascorso, un appuntamento alla porta San Lazzaro con l’avvocato Rossini. Io risposi negativamente, dissi di essere effettivamente un avvocato ma di Napoli e di chiamarmi Montefredini e non Re. Doveva esserci un equivoco…Assunsi l’atteggiamento di un cittadino indignato che aveva le carte in regola e che chiedeva la verifica dell’esattezza delle sue affermazioni.”
“L’ufficiale pareva colpito dalla mia sicurezza…Ad un certo punto mi fece vedere un’agenda nella quale era scritto alla pagina che portava il 2 agosto “ore 8, alla porta San Lazzaro, avvocato Re, romano”. Questa agenda l’aveva trovata nell’appartamento di Rossini, mi disse, che era un capo partigiano. “…Fui riaccompagnato in basso e poco dopo, il solito toscano venne a dirmi di stare tranquillo, che avevo fatto un’ottima impressione e che gli avevano detto di comparare per me tutto quello di cui avevo bisogno. Anche Campioli e Giacchetti non furono toccati. Chi subì un terribile trattamento fu Jacchia che vidi riportare in basso dopo gli interrogatori, sempre più dolorante. L’ultima volta era trascinato giù per le scale perché non si reggeva in piedi. Poi non lo vidi più. Come è finito? …Forse fui io l’ultimo a vederlo vivo, anche se in quelle condizioni”… “Fui liberato il 16 agosto”.
Il comando partigiano propose, in verità, uno scambio con alti ufficiali tedeschi, ma inutilmente. Verso la fine di agosto, Jacchia fu portato via in segreto da Parma, e di lui non si ebbero più notizie.
La sua fine fece enorme impressione negli ambienti antifascisti, che non lo dimenticarono. A guerra finita, per iniziativa del vice comandante militare del Corpo Volontari della Libertà, Ferruccio Parri, la presidenza del Consiglio dei Ministri gli conferì il 10 novembre del 1949 la medaglia d’oro alla memoria. Lettere ammirate e affettuose giunsero alla vedova, lapidi furono apposte nel 1949 sull’edificio dove abitò e lavorò, in via d’Azeglio 58 e nel Palazzo di Giustizia di Bologna, a cura del Consiglio dell’Ordine Forense.