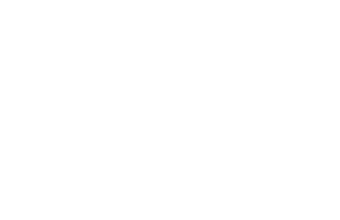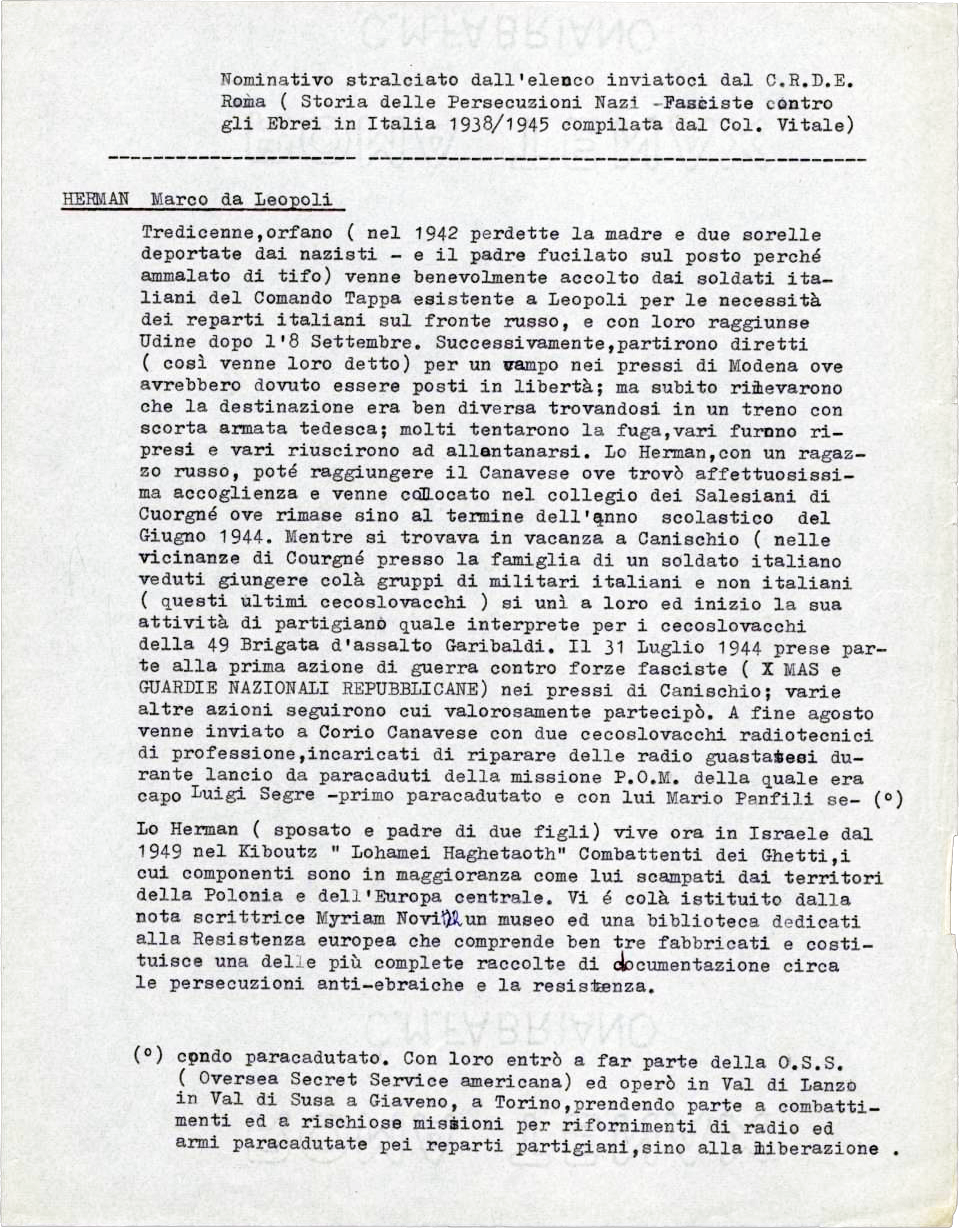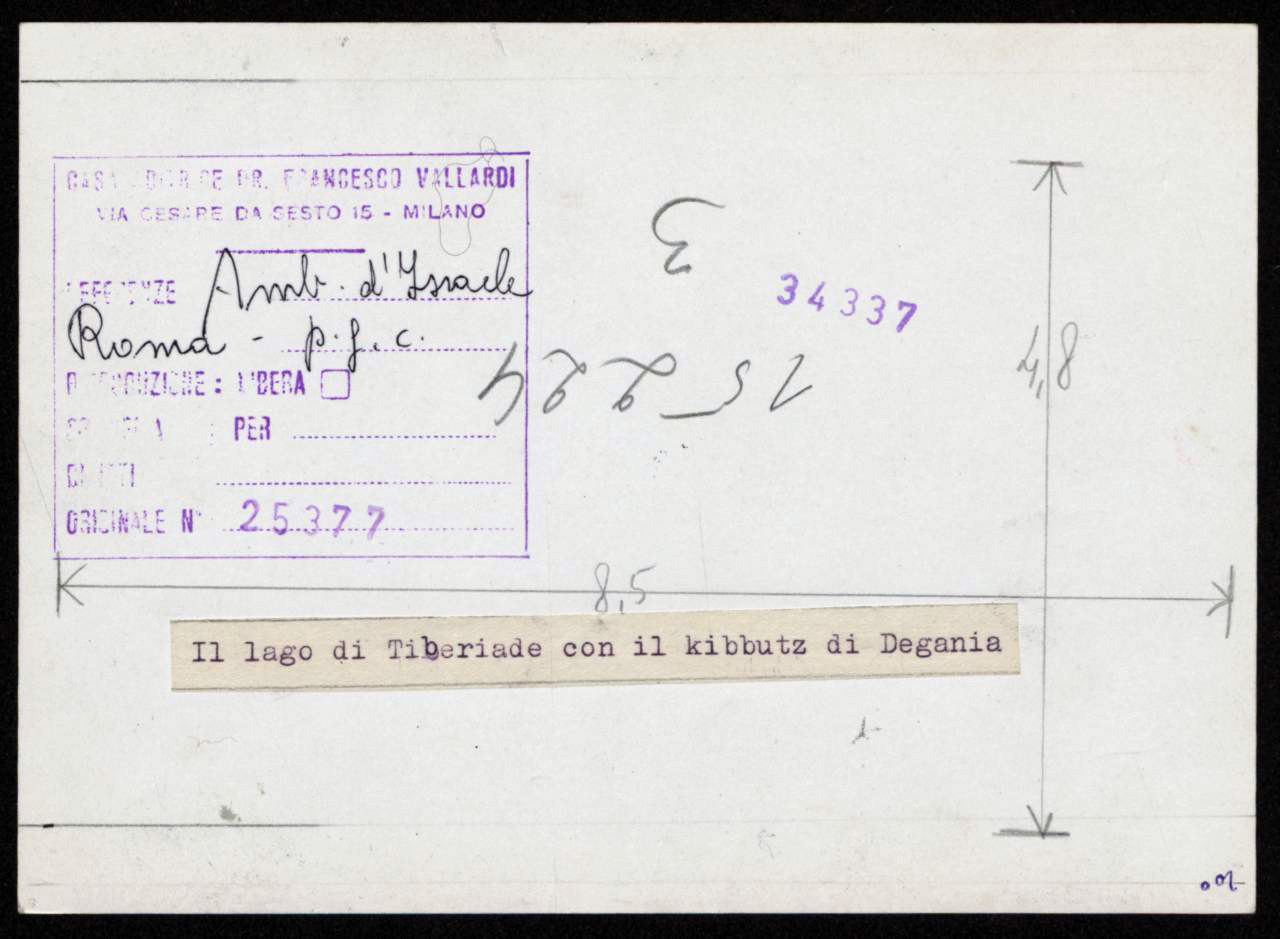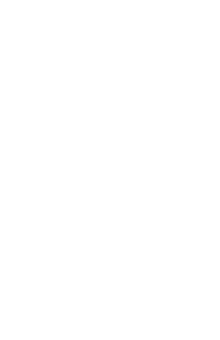Marco Herman
Nato a Leopoli, cresciuto tra il ghetto e la città, venne aiutato dai soldati italiani a fuggire in Italia, dove per la sua conoscenza delle lingue venne reclutato dall’OSS per collaborare con i partigiani.
Marco Herman nacque il 25 ottobre 1927, primogenito di una famiglia povera di Leopoli. Il padre era cappellaio, e abitavano tutti in un’unica stanza che fungeva anche da laboratorio. Nel suo libro Marco ci racconta dell’invasione tedesca, della fame, del freddo, delle retate contro gli ebrei, e del Ghetto, da cui lui e il fratello erano riusciti a rimanere fuori, continuando a dare un aiuto alla famiglia rimasta all’interno.
“Quando aprii l’uscio il mondo parve crollare intorno a me: mio padre era seduto sul letto, con il capo fra le mani, e non c’era nessun altro. “E mamma”? chiesi “e le bambine?”. Non rispose. Allora capii. Michele ed io posammo la testa sulle sue ginocchia. Solo quando sentii la sua mano sul mio capo scoppiai a piangere e piangemmo tutti e tre. Il giorno dopo ritornammo per fargli un po’ di coraggio, ma trovammo l’appartamento vuoto. Avevano preso anche papà. Alla fine del 1942 non avevo più nessuno da andare ad aiutare nel ghetto.”
I due fratelli dormivano in una cantina fredda e buia, con il continuo rischio di essere fermati. Di giorno, per trovare qualcosa da mangiare, gironzolavano da un cortile all’altro, nelle chiese, o nei dintorni di un comando militare italiano.
Durante uno di questi giri per la città suo fratello Michele venne fermato e interrogato. Marco non lo rivide mai più. Rimasto solo, l’unica soluzione era partire con gli italiani, che si preparavano a tornare in patria. Il capitano della guarnigione aveva accettato di aiutare lui e alcuni orfani russi e polacchi, dando loro qualche vecchia divisa per camuffarsi durante il viaggio.
“In stazione, passammo davanti alle SS di guardia, tre soldati italiani davano la mano a tre bambini, ma nessuno ci fermò. Avevo il cuore in gola dall’emozione. Poi la locomotiva fischiò e il treno si mosse.”
Attraversarono la Cecoslovacchia, la Germania, l’Austria, giungendo infine alla frontiera di Tarvisio. Lì Marco esibì il suo documento falso, su cui era riportato il nome Marco Vladimiro Ilkow. Dopo l’8 settembre la situazione si complicò di nuovo.
“Il comandante convocò i militari che erano disposti a prendersi cura di uno di noi ragazzi fuggiti dalla Polonia, consegnò a ciascuno qualche centinaio di lire e un ragazzo. Io fui preso sotto la protezione di Giovanni Ferro. Verso sera giungemmo a Mestre. Là incontrammo soldati tedeschi armati che ci circondarono e ci arrestarono. Gli italiani, dopo la dichiarazione di armistizio, erano diventati per i tedeschi, nemici, e andavano puniti con la deportazione in Germania.”
Marco e Giovanni Ferro furono così costretti a salire su un treno scortato dai tedeschi. Con loro c’era anche Silvio Vassili, uno dei ragazzini russi.
“Con Silvio, decidemmo che, a qualsiasi costo, non saremmo andati in Germania, l’unica speranza consisteva nella fuga. Giovanni e Luigi, il soldato protettore di Silvio, scrissero lettere di saluto ai loro genitori invitandoli ad accoglierci come figli, ci diedero poi istruzioni necessarie per raggiungere le loro case. Ci buttammo dal vagone poco prima di Verona, mentre il treno rallentava”.
Con l’aiuto dei ferrovieri i due ragazzi riuscirono a salire prima su un treno per Milano, e poi su un altro diretto a nord-ovest.
“Io dovevo proseguire fino a Canischio di Cuorgnè, a casa del mio amico soldato Giovanni Ferro. Vi giunsi con grande fatica. Fui accolto dalla famiglia Ferro come un figlio, dormivo nel letto di Giovanni, aiutavo i suoi genitori nei campi”.
Lì Marco venne iscritto al collegio Giusto Morgando dei salesiani, per continuare gli studi.
“Nel giugno del 1944, mentre pranzavo in casa della mia nuova famiglia a Canischio, vidi dalla finestra un camion carico di soldati e una mitragliatrice, mi accorsi subito che non erano tedeschi e allora, malgrado le proteste dei miei protettori Ferro, andai in paese a vedere di che cosa si trattava. Vidi un gruppo di giovani italiani armati che salutavano calorosamente i nuovi arrivati. Gli italiani non riuscivano a farsi capire e i due gruppi cercavano di comunicare a gesti. Erano militari cecoslovacchi arruolati dai tedeschi per fare la guardia agli impianti di interesse militare, ma ora intendevano disertare e unirsi ai partigiani. Mi offrii come interprete e fu così che, a 16 anni, entrai a far parte della resistenza italiana. I miei compagni erano della 49° Brigata d’assalto Garibaldi.”
In seguito a Herman fu chiesto di riparare una radio trasmittente lanciata da un aereo alleato assieme a due paracadutisti dei servizi segreti americani. Uno di loro era Luigi Segre. Herman, grazie alla sua conoscenza delle lingue, venne reclutato dall’OSS (Office of Strategic Services), per la missione denominata POM.
Compito di questa era dare informazioni di interesse militare nella zona, trasmettere le richieste di armi da parte dei partigiani e provvedere al recupero dei lanci.
“Nel novembre del 1944, trasferimmo la radio trasmittente in una cascina ad alcuni chilometri da Giaveno, non lontano da Torino. Avevo una carta di identità falsa con la quale viaggiavo spesso in treno per andare a Torino dove il capo della missione, Segre, si era sistemato. Gli portavo messaggi e ne prelevavo altri. Li scrivevo su fogli di carta sottilissimi, tipo cartine delle sigarette, facili da nascondere nelle calze o nei guanti, che potevo “perdere” in caso di pericolo.”
Dopo la Liberazione, appena la strada per Torino fu libera, Marco fu richiamato da Segre. Il 10 maggio i membri della missione POM si recarono a Firenze, dove c’era la sede centrale dell’OSS. La guerra era finita.
“Ma io, pensò Marco, il militare Marco Ilkov come mi ero chiamato fino a quel momento secondo i miei documenti falsi polacchi, l’ebreo Marco Herman nella realtà; il ragazzo che ero stato, l’uomo che rapidamente ero divenuto, che cosa speravo?
Dovevo tornare a casa a vedere se qualcuno dei miei era ancora vivo. Ci misi qualche mese per giungere a Leopoli. Passai là il mio diciottesimo compleanno. Di tutta la mia famiglia ero rimasto io, unico ed ultimo.
Poco dopo, decisi di trasferirmi in Israele. Tutto quello che volevo era cambiare lo zaino con un armadio.
Su una collina dalla quale si godeva una vista meravigliosa sul golfo di Haifa sorgevano alcune capanne di legno e un gruppo di tende, dal quale nacque il kibbutz Lohamei Haghettatot, là costruii la mia nuova vita.”